L’Unione
europea si basa, secondo il trattato di Maastricht,
su tre pilastri
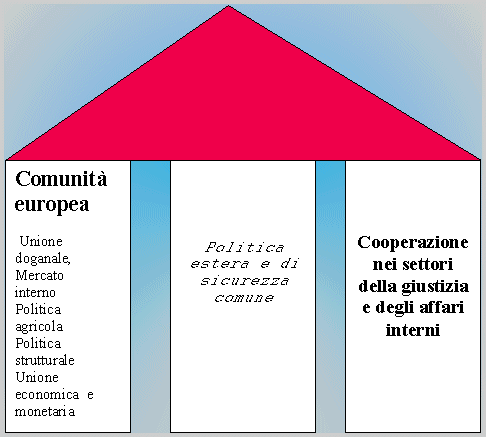
Il nostro gruppo ha
approfondito le relazioni esterne ossia quelle
relazioni che l’UE intrattiene coi Paesi terzi e
le organizzazioni internazionali nel settore
economico e commerciale. Nonostante il grande rilievo
che assumono nel quadro della politica estera, esse
vanno tuttavia distinte, dal punto di vista del
contenuto e sotto il profilo giuridico, dalla
politica estera e di sicurezza comune (PESC), che ha
per oggetto le relazioni di natura strettamente
politica tra l’UE e i Paesi terzi e le
organizzazioni internazionali. Le relazioni estere, i
cui principali elementi sono costituiti dalla
politica commerciale comune, la politica di
associazione e la politica di sviluppo, formano,
assieme alla PESC, la base della politica estera
europea.
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
EUROPEA COMUNE
Tradizionalmente
l’UE agiva per conto dei suoi Stati membri nei
campi delle relazioni economiche esterne delle
politiche dello sviluppo. Nel novembre 1993 è stato
fissato dal trattato di Maastricht un nuovo
obbiettivo: "L’attuazione di una politica
estera e di sicurezza comune, compresa la definizione
a termine di una politica comune di difesa".
- Il trattato
fissa per la PESC i seguenti obbiettivi:
- la difesa dei
valori comuni, degli interessi fondamentali e
dell’indipendenza dell’Unione;
- il
rafforzamento della sicurezza
dell’Unione e dei suoi Stati membri in
tutte le sue forme;
- il mantenimento
della pace e il rafforzamento della sicurezza
internazionale, conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai
principi dell’Atto finale di Helsinki e
agli obbiettivi della Carta di Parigi;
- la promozione
della cooperazione internazionale;
- lo sviluppo e
il consolidamento della democrazia e dello
stato di diritto, nonché il rispetto dei
diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.
L’UE non deve
far fronte tanto a minacce militari quanto piuttosto
a problemi di sicurezza nucleare, criminalità
organizzata, catastrofi ambientali, traffico illegale
di materiali nucleari, sovrappopolazione, povertà,
migrazioni di massa, conflitti etnici e regionali ai
confini dell’Unione.
Le procedure
decisionali sono intergovernative e si differenziano
quindi da quelle che si applicano alle relazioni
esterne. Il controllo generale è affidato al
Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo e al
Consiglio dei ministri: il Consiglio europeo
definisce i principi e gli orientamenti generali
della PESC e adotta tutte le sue decisioni
all’unanimità. La Commissione europea partecipa
a tutte le discussioni, può avanzare proposte e
dispone del diritto di iniziativa. Il Parlamento
Europeo viene consultato regolarmente ma non ha
poteri diretti.
Una volta adottata una
posizione comune in Consiglio, gli Stati membri sono
tenuti ad adeguare ad essa le loro politiche
nazionali. Le azioni congiunte impegnano gli stati
membri a seguire una determinata linea d’azione
a sostegno di una posizione comune.
Non sarebbe corretto
affermare che dal suo inizio nel 1993, la politica
estera dell’UE abbia ottenuto scarsi risultati.
Oggi che l’UE e i suoi Stati membri hanno una
libertà di manovra molto maggiore nell’ambito
di un quadro istituzionale unico che si occupa di
questioni politiche, economiche, commerciali e
giuridiche, si sta infatti gradualmente sviluppando
un approccio globale e coerente in materia di
politica estera nei casi in cui la PESC si è
mostrata poco efficace, la causa del fallimento può
essere attribuita in larga misura alla mancanza di
progressi sostanziali verso l’integrazione delle
strategie politiche ed economiche dell’UE nei
confronti dei paesi terzi e all’incapacità di
esprimere un forza militare credibile. Per superare
questo limite, l’UE deve definire più
chiaramente gli interessi comuni e a tale scopo è
necessario trovare una formula che faciliti un
processo decisionale. La soluzione più ovvia è
ricorre più ampiamente al voto a maggioranza in seno
al Consiglio dell’UE, per deliberare su
questioni di politica estera. Si spera che, in
seguito alla conferenza intergovernativa del 1996, si
riesca a trovare una soluzione a questa aporia
diplomatica.
La politica commerciale
prevista dal trattato
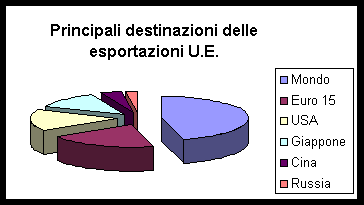
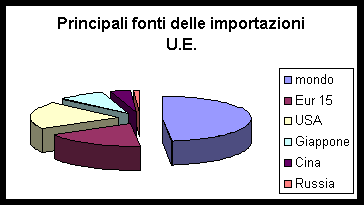
La politica commerciale
prevista dal trattato copre tutti gli accordi UE con
i paesi terzi relativi alle importazioni ed
esportazioni di merci. Tali accordi possono essere
limitati a particolari paesi terzi o gruppi di paesi
terzi, oppure possono avere dimensione globale, come
è avvenuto nella recente tornata di negoziati
conclusi nell’ambito del GATT nel dicembre
1993.Il fatto che l’UE conduca una politica
unica e coerente nei confronti del resto del mondo ha
fatto della politica commerciale comune una delle
chiavi di volta della politica dell’Unione. Già
i padri fondatori del trattato di Roma avevano
previsto una politica commerciale comune che doveva
costituire il logico complemento alla creazione
dell’unione doganale tra gli Stati membri.
La politica commerciale
comune prevede la negoziazione di accordi tariffari e
commerciali, l’uniformizzazione delle misure di
liberalizzazione, della politica d’esportazione
delle misure di protezione commerciale da adottare,
ad esempio nei casi di Dumping o di sovvezioni
ecc… Il potere esclusivo di negoziare della
Commissione europea nel quadro della politica
commerciale comune si limita essenzialmente ai
negoziati relativi ai beni di consumo. Quelli nel
settore dei servizi, della protezione della
proprietà intellettuale e degli investimenti diretti
all’estero acquisiscono tuttavia un peso sempre
maggiore a livello internazionale, in particolare per
l’UE. L’importanza dei servizi è andata
aumentando sempre più negli ultimi decenni. Una
percentuale in costante aumento degli scambi
mondiali, inoltre, riguarda la proprietà
intellettuale, dei prodotti farmaceutici, del
software informatico, dell’industria musicale,
ecc… In futuro si dovranno definire chiaramente
i poteri dell’UE in questi settori, poiché fino
ad oggi essi sono stati fissati in modo
approssimativo dando così origine a inutili dispute
procedurali fra l’UE e i suoi Stati membri.
L’UE aiuta attivamente i Paesi in via di
sviluppo; le sue relazioni commerciali si imperniano
sulla convenzione di Lomè, di cui sono firmatari 70
Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
Esso introduce il rispetto dei diritti dell’uomo
e dei principi democratici nonché una procedura
specifica in caso di violazione di questi principi e
prevede ormai risorse finanziarie destinate a
sostenere la promozione dei diritti dell’uomo e
ad appoggiare misure di democratizzazione, di
rafforzamento dello stato di diritto e di sana
gestione degli affari pubblici.
Mediterraneo e Medio Oriente
La politica
dell’UE nei confronti della regione del
Mediterraneo e del Medio Oriente trova
sostanzialmente origine negli anni ’70 grazie ad
un serie di accordi che hanno durata illimitata e si
compongono essenzialmente di due elementi :
- concessioni
commerciali a favore dell’esportazione
di prodotti mediterranei verso il mercato
comunitario ;
- cooperazione
economica e finanziaria : l’aspetto
finanziario è finalizzato alla realizzazione
di azioni e atti di sviluppo.
All’inizio degli
anni’90, un altro rilevante passo è stato
compiuto con l’adozione mediterranea rinnovata
che ha portato a un netto aumento delle risorse
finanziarie e all’apertura a nuovi settori alla
cooperazione.
America latina
La Comunità
contribuisce ad iniziative di natura istituzionale
che si basano su tradizioni giuridiche originali,
viene a favore di infrastrutture d’informazione,
di assistenza e di formazione. Altre azioni
riguardano il rafforzamento dei pubblici ministeri
attraverso un’assistenza tecnica oppure
l’appoggio alle attività di formazione. Un
programma in America centrale prevede in particolare
il controllo di casi portati davanti alla Corte
interamericana dei diritti dell’uomo. Per quanto
riguarda 11 paesi dell’America centrale un
progetto ha permesso di organizzare un serie di
seminari, con l’obiettivo di demoltiplicare i
programmi di formazione giuridica in ciascuno dei
paesi interessati. Dal1992, il programma pluriennale
di protezione dei diritti dell’uomo
nell’America centrale, che beneficia del
sostegno comunitario, dà la priorità a progetti di
istruzione sensibilizzazione del personale della
polizia, delle forze armate,
dell’amministrazione della giustizia e dei
penitenziari. L’originalità di questa
iniziativa risiede nel fatto che concretizza una
stretta relazione di partenariato
sull’apprezzamento della situazione dei diritti
dell’uomo e su progetti specifici di assistenza
giuridica e di sostegno dell’apparato
giudiziario. Questo tipo di azione è stato esteso a
varie paesi dall’America latina.
Asia
In occasione del
vertice di Essen nel dicembre del 1994, il Consiglio
europeo ha varato un nuova legge la "nuova
strategia asiatica", mirante a realizzare un
considerevole sviluppo delle relazioni verso gli
Stati asiatici nel commercio e nella cooperazione
industriale così come della collaborazione tra
imprese, ricerca e sviluppo, sia su base bilaterale
che in una più ampia prospettiva regionale. A tale
proposito, in occasione del primo vertice
euro-asiatico che si è tenuto a Bankok
all’inizio di Marzo 1996 sono stati conseguiti i
primi importanti progressi : la comunità e i 10
paesi asiatici di maggior peso economico hanno
individuato in questa occasione nell’avvio
dell’economia di mercato, la liberalizzazione
commerciali non discriminatoria e forme di
cooperazione regionale aperte la base di un solido
partenariato euro-asiatico e hanno deciso di avviare
consultazioni nel quadro dell’Organizzazione
mondiale dei commerci, nonché concreti programmi di
azioni nei settori quali la promozione degli
investimenti e la semplificazione delle procedure
doganali.
Africa
L’UE si è
impegnata non soltanto inviando aiuti ai paesi in via
di sviluppo o in guerra. Principale obiettivo della
politica estera rivolta a tali stati è lo sviluppo
economico e l’instaurazione di una pace
permanente. A tale scopo opera l’ECHO, creata
nel 1992 come un’associazione che gestisce e
coordina le operazioni umanitarie UE nei paesi terzi.
È stato recentemente adottato un piano globale di 14
MECU a favore delle popolazioni angolane, che
privilegia la sanità e consentirà di ripristinare
gli ospedali delle arre rurali, segnatamente nelle
regioni rimaste per troppo tempo inaccessibili alle
organizzazioni umanitarie. Vengono altresì sostenute
attività di sminamento mirato per agevolare
l’accesso alle popolazioni isolate. Con il suo
aiuto umanitario, ECHO partecipa quindi attivamente
all’apertura del paese e del processo di pace,
ristabilendo la fiducia grazie alla presenza
internazionale e all’aiuto ai più indigenti.

